Fotografia e cinema, da passioni a professioni. In molti non esiterebbero a dire che chi è riuscito in tale salto sia stato fortunato. Non solo io credo, con buona pace di Woody Allen secondo il quale “Meglio avere fortuna che essere bravi”. Per riuscirci è necessaria una visione profonda del percorso che si sta per intraprendere, ma soprattutto quel qualcosa lo si deve sentire dentro in modo autentico, sorretto naturalmente da un talento che nasce con colui che lo possiede ma che, esigente, richiede di essere affinato per spiccare il volo. Ma non basta: ci vuole anche una certa sensibilità. Non tutti siamo in grado di cogliere dal reale le stesse cose e le stesse sfumature, ecco quindi che chi ha tra le mani quegli strumenti (siano essi una macchina fotografica o una macchina da presa) deve prima guardare oltre la superficie delle cose per restituire quel qualcosa in più che l’occhio umano nella media non riesce a percepire, suggerendo inesplorati modi di intendere il mondo. Spesso impensabili, altre volte peggiori ed altre volte ancora nettamente migliori rispetto a quello che noi, nella nostra realtà, avevamo pensato e forse troppo frettolosamente etichettato come “il meglio”.
Lo sa bene Giulio Tonincelli fotografo e filmmaker indipendente, nato a Brescia nel 1984. Co-founder di Moonwalk Studio e programmatore dell’Orvieto Cinema Fest. Realizza progetti per diverse ONG viaggiando tra Vicino Oriente, India, America Latina e Africa. I suoi progetti sono stati selezionati in numerosi festival internazionali in oltre 20 paesi.
Come e quando nasce la tua passione per la fotografia?
“La mia passione per la fotografia (e in generale per il mondo dell’immagine), nonostante mia madre quand’ero piccolo si dilettasse con questa pratica, nacque durante gli studi all’Accademia di Belle Arti di Brescia. L’incontro con i professori, i compagni e l’atmosfera respirata in quegli anni mi diedero stimoli e prospettive alternative da cui guardare e alle quali tendere. Si instaurò in me una voglia di scoprire e raccontare il mondo attraverso le immagini, fisse o in movimento, così iniziai a sperimentare”
La tua formazione
“In Accademia studiai graphic design ma alcuni corsi erano improntati sul cinema e la fotografia. Una volta conseguita la laurea triennale decisi di dedicarmi totalmente alla fotografia ma non più all’interno delle mura accademiche, che nonostante fossero aperte rimanevano comunque limitanti, così iniziai un percorso sul campo che mi portò a Milano. Qui oltre a fare l’assistente fotografo conobbi un collettivo che lavorava in ambito video, con i quali si instaurò un rapporto di amicizia e collaborazione che si protrasse per diversi anni. In quegli stessi anni collezionai anche esperienze tra loro diverse, come per esempio una parentesi lavorativa newyorkese in due diversi studi fotografici, su alcuni set cinematografici italiani e in missione a documentare le attività di ong e associazioni. Se l’Accademia mi diede un punto di partenza, una lente, un obiettivo dal quale far emergere il mio sguardo, gli anni successivi mi aiutarono a scoprire i mezzi e le tecniche per potermi esprimere. Al contempo anche il mio pensiero e la mia visione si stavano modellando”.
Da passione a professione, quando hai capito che quel famoso salto sarebbe stato possibile?
“Più che capire che potesse diventare una professione, la mia era una speranza e una rincorsa verso questa idea. La quale persiste, perché nonostante mi sia laureato 14 anni or sono, ancora oggi e sotto molti aspetti non è semplice riuscire a definirla professione. O meglio, lo è se prendiamo in considerazione il termine con accezione derivante dal latino, che significa “dichiarare, professare”. Negli ultimi secoli è diventato sinonimo di lavoro, attività per ricavare guadagno. Mentre invece dovrebbe intendersi come una sorta di dichiarazione della propria scelta di vita. La professione delle proprie idee, opinioni o sentimenti. Allora con questa visione forse un po’ romantica, il fare arte, che sia cinema, fotografia o altro, potrebbero essere considerate professioni! Certo è che la cultura in generale (soprattutto in Italia), se non consideriamo certi livelli difficilmente raggiungibili, è spesso calpestata e maltrattata a livello sociale ed economico”.
Qual è il lavoro al quale sei maggiormente legato e perché?
“Happy Today”. Nato con la semplicità di vivere l’esperienza personale del qui e ora (divenuta là e allora, fu girato in un villaggio nel nord dell’Uganda nell’ottobre 2016) e del ritrovarsi in un luogo distante e ai miei occhi esotico. Assorbire tutto ciò che accadeva libero da pressioni sociali, politiche e artistiche. Non vi era alcuno script e nemmeno la presunzione di realizzare un film che dovesse piacere, rimanere all’interno di certi paletti o accontentare qualcuno. Nonostante fossi lì per documentare una realtà sostenuta da Fondazione Ambrosoli, dove nel villaggio di Kalongosupporta un ospedale e una scuola di ostetricia, ebbi spazio e possibilità di muovermi in quel contesto in modo indipendente. L’Uganda è tra i paesi con la più alta mortalità materna e infantile e scavando a fondo nel passato delle persone che popolano queste terre degli Acholi, si incontrano momenti di estrema sofferenza che formano e rafforzano la loro fede nella vita. Da qui nasce la convinzione che aiutando gli altri si possa, in qualche modo, estirpare il proprio dolore. Ne scaturì così l’idea di realizzare il ritratto di una ragazza, in cui molte donne avrebbero potuto identificarsi, che studia per diventare ostetrica e aiutare le donne a partorire. Porre così i riflettori su persone che non urlano la loro esistenza ma che hanno da raccontare più col silenzio delle loro azioni, che non con le parole. Quel che emerge è lo spettacolo della vita, che la natura genera incondizionatamente con forza travolgente e libertà, senza sosta, relegando in secondo piano ogni complessità. Evitando la drammaticità ma provando a trasmettere una visione delicata, umile ma non banale, e positiva dell’umanità.
Così, in modo naturale, i pezzi del puzzle si incastrarono e tutto questo diventò un documentario breve che fu selezionato in una cinquantina di festival in oltre 20 paesi, ottenendo svariati premi e riconoscimenti internazionali. Grazie al progetto viaggiai in Italia e in altri paesi partecipando a festival interessanti e stimolanti.
Con una certa onestà intellettuale ammetto che dopo quel lavoro, oltre all’ansia da prestazione e di riconferma, scoprii dinamiche di un mondo (quello del cinema) che poco conoscevo precedentemente se non da spettatore. Dunque il pensiero che ne scaturì e l’approccio a nuovi progetti, pur rimanendo sempre fedele all’idea di indipendenza, iniziarono ad essere viziati (non condizionati) dalla consapevolezza che taglio, durata, mode del momento e tanto altro, influenzano in modo consistente la visibilità e (termine orrendo) la spendibilità del progetto. Di conseguenza anche i bandi a cui si vuole accedere per realizzare film e ovviamente sulle selezioni e distribuzione. Da piccolo non credo di aver mai aspirato a diventare regista o fotografo, a pensarci bene avrei voluto più banalmente fare il calciatore o l’architetto. Il fatto è che nemmeno ora saprei dirlo con precisione se mi ponessero questa domanda, ma la fotografia e il video sono i mezzi con i quali sento di poter esprimere il mio pensiero e la mia visione della vita”.




 Giornalista pubblicista, ha conseguito la laurea magistrale in Editoria e Giornalismo all’Università degli Studi di Verona discutendo la tesi “La donna nel cinema di Federico Fellini: musa tra sogno e realtà”. Attratta dalla parola scritta fin da quando sedeva sui banchi di scuola, considera foglio e penna dei formidabili compagni di viaggio. Non le piace fermarsi alla superficie, per questo ama cogliere l’essenza più vera delle persone e delle cose delle quali si circonda, convinta che non solo “la bellezza salverà il mondo” ma che anche la gentilezza disinteressata, la sana curiosità e un pizzico di Rock and Roll possano contribuire ampliamente alla causa.
Giornalista pubblicista, ha conseguito la laurea magistrale in Editoria e Giornalismo all’Università degli Studi di Verona discutendo la tesi “La donna nel cinema di Federico Fellini: musa tra sogno e realtà”. Attratta dalla parola scritta fin da quando sedeva sui banchi di scuola, considera foglio e penna dei formidabili compagni di viaggio. Non le piace fermarsi alla superficie, per questo ama cogliere l’essenza più vera delle persone e delle cose delle quali si circonda, convinta che non solo “la bellezza salverà il mondo” ma che anche la gentilezza disinteressata, la sana curiosità e un pizzico di Rock and Roll possano contribuire ampliamente alla causa. 




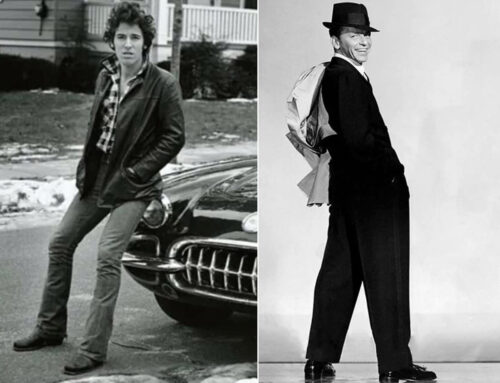


Scrivi un commento